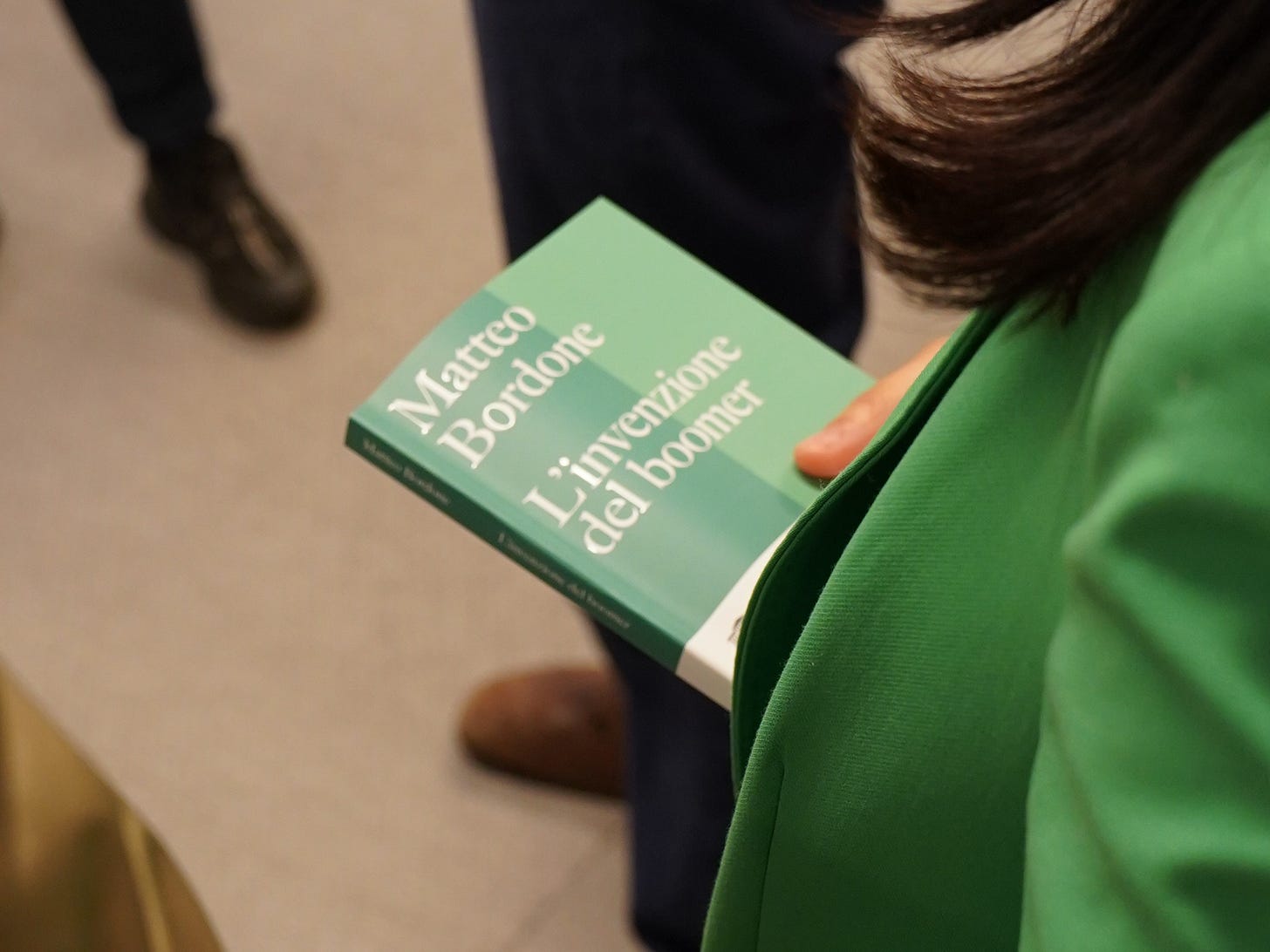Podcast, boomer e altre stranezze
Una chiacchierata con Matteo Bordone sull’arte di fare informazione seria, senza prendersi troppo sul serio.
Ciao! Questa è la newsletter de I MILLE. Si chiama Forward perché da qui proviamo a guardare in avanti (e anche perché se poi le cose che scriviamo ti piacciono le puoi inoltrare a qualcuno che ti piace).
Come te, altre +1800 persone che lavorano nel mondo della comunicazione, del marketing e del digitale leggono I MILLE Forward, e +26.000 seguono quello che abbiamo da dire su LinkedIn e Instagram.
Say Hello to Matteo Bordone
Matteo Bordone ha esordito giovanissimo, a 27 anni, conducendo un programma quotidiano su Radio 2 che si chiamava Dispenser. Poi è passato a condurre insieme a Luca Sofri Condor, sempre su Radio 2, e ha avuto diverse esperienze televisive: opinionista a Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, spalla di Geppi Cucciari a G Day, conduttore di Extrafactor nell’ambito di X Factor, e così via. Infine è approdato al quotidiano online Il Post, dove risiede felicemente tuttora e per il quale ha prodotto diversi podcast, il principale dei quali è Tienimi Bordone, un appuntamento quotidiano oggi arrivato a più di 1200 puntate. Lontano dai microfoni, per la casa editrice UTET ha pubblicato il saggio L’invenzione del boomer (2023). È stato intervistato dallo scrittore Matteo B. Bianchi, per il ciclo di incontri “I MILLE Welcomes”.
Il filo conduttore della tua carriera sembra essere la voce: prima radio, ora podcast. Partiamo da una domanda apparentemente semplice: qual è la differenza tra giornalismo scritto e giornalismo parlato?
La differenza principale, secondo me, è il contesto.
Il contesto è tutto. Dentro a una testata tu hai un senso come firma, indipendentemente dal tono.
Ho scritto per periodici come Wired, Rolling Stone, GQ e altri, ma per tanti anni ho scritto anche quotidianamente sul mio blog, Freddy Nietzsche. È così che mi sono abituato a questa pratica della scrittura quotidiana, a rincorrere le cose che succedevano cercando tagli interessanti ma personali. Una palestra fantastica.
Poi sono arrivati i social network e quel periodo d’oro è evidentemente finito. Sono saltati i contesti e il panorama si è complicato parecchio.
Oggi abbiamo l'account ufficiale della Casa Bianca con la foto di Trump vestito da Papa. Account ufficiale, ripeto, quindi è normale non sapere più come reagire.
Il tuo podcast, Tienimi Bordone, sembra proprio l’erede naturale di Freddy Nietzsche: episodi brevi, meno di dieci minuti, dove mischi informazione, passioni e comicità. Com’è nata questa formula?
Un po’ per caso, come tutte le cose divertenti.
Quando hanno chiuso Condor, Luca Sofri ha aperto Il Post. Dopo qualche tempo, Il Post ha lanciato un abbonamento che dava accesso a contenuti esclusivi e newsletter, e ha funzionato subito. Successivamente è stata aperta una sezione podcast, gratuita per i primi sei mesi, poi accessibile solo agli abbonati.
Ho proposto a Luca un podcast molto personale. Ho inciso due puntate di prova da quattro minuti, le ho buttate in rete ed è partita così, con un manipolo di ascoltatori pochi ma affezionatissimi, praticamente una carboneria.
Poi è arrivato Francesco Costa con il suo Morning, e gli abbonamenti sono cresciuti tantissimo. Con il Covid e il lockdown, la gente ha iniziato ad ascoltare podcast ancora di più perché stavano chiusi in casa, con le ambulanze fuori e la paura di morire. Ogni mattina Francesco raccontava quello che succedeva, spesso cose tremende, e io pensavo agli abbonati che la mattina si svegliavano, ascoltavano disastri e tragedie, e finivano più mogi di prima.
Così, visto che mi piace fare anche il deficiente, ho iniziato a mettere dentro Tienimi Bordone effetti, vocine e personaggi inventati, e la cosa ha preso piede. Si è creato un rapporto particolare con gli ascoltatori e il mio piccolo mondo è cresciuto.
Oggi gli abbonati sono più di 80.000, parecchi. Però ho sempre mantenuto questa formula, che è, per dirla in breve, un po' fatti miei e un po' informazione.
Come mantieni l’equilibrio tra queste due componenti?
Funziona così: vago alla ricerca di spunti che so già possono funzionare, ormai dopo 1200 puntate so come vanno le cose. Poi trasformo questi spunti in argomenti.
All’inizio facevo anche tirate lunghissime, invettive da 10 minuti, poi ho capito che era meglio diversificare. Posso trattare temi tremendi, ma devo renderli un po’ più comodi per chi ascolta. Non vuol dire edulcorare o evitare argomenti spinosi, ma creare uno spazio dove si possa ridere e andare sopra le righe. Magari con qualche vocina.
Ovviamente questo comporta il rischio di sembrare superficiale perché uso strumenti comici. Per anni ci sono rimasto male, ma ormai ho capito che in Italia se dici una cosa seria con giacca e cravatta sei serio, mentre io preferisco dire cose profonde in maniera più leggera e carezzevole.
Per rispondere alla domanda, credo che la salvezza sta proprio in questo equilibrio.
Nel contesto dei podcast quotidiani del Post so che gli altri sono più seri, quindi io posso giocarmi l’elemento ironico. Ho il vantaggio di poter parlare anche di cretinate o notizie strane, ma il cuore del podcast non è la notizia, è come viene elaborata. Nessuno da me si aspetta attualità, ma informazioni, commenti e intrattenimento, quello sì.
Il Post è un quotidiano indipendente, un’impresa culturale che funziona, dove il pubblico paga volentieri per contenuti esclusivi. Qual è secondo te il segreto di questa eccezione?
Il Post fa un giornalismo che non c'era: esplicativo, chiaro, diretto, senza virgolettati inventati o clickbait.
Una proposta diversa, che ha richiesto tempo per affermarsi proprio per questi articoli solo apparentemente “scarni”, ma in realtà con un sacco di ricerca documentata alle spalle. Ora però ha un pubblico ampio di abbonati.
Anche molti creator di YouTube hanno un pubblico disposto a pagare, se c’è partecipazione e appartenenza. Questo, per me, è centrale. I contenuti molto settoriali si fanno pagare facilmente: se sei appassionata di flauto traverso e trovi un canale dedicato, un euro al mese lo dai volentieri.
Non sono l’analista perfetto, ma credo che Il Post abbia avuto successo perché è informazione ampia ma con personalità, e fa sentire le persone parte di un progetto.
In mezzo al caos informativo, fake news e overload di contenuti, dove scavi per trovare storie affidabili?
Nei posti più improbabili.
Sembrerà banale, ma passo ore nelle pagine più assurde di Wikipedia, come per esempio quella che confronta rastafarianesimo e giudaismo, con cui posso riempire una puntata intera. Naturalmente leggo anche il New York Times e il Post, ma il meglio arriva sempre dai dettagli più strani e nascosti.
Prima accennavi al fatto che con l’arrivo dei social network è saltato tutto il contesto, e che oggi puoi vedere contenuti stranianti come una foto di Trump vestito da Papa.
Cosa pensi del fatto che, in questo scenario di comunicazione così surreale e complicato, tante aziende che avevano costruito intere campagne intorno a temi come l’inclusività, la sostenibilità ambientale e il sociale si siano ritrovate improvvisamente disorientate, costrette a rivedere piani e messaggi?
Il rapporto tra attivismo e brand è diventato molto ingarbugliato, e secondo me è un problema profondamente americano, anzi, californiano.
Nasce proprio da lì, dalla cultura della West Coast, dove per anni aziende come quelle di Musk e Zuckerberg hanno fatto soldi a palate in un ambiente praticamente senza regole, convinte che la società si governi in maniera tecnocratica.
È un po’ una pappa che mescola capitalismo estremo e una versione distorta del calvinismo americano, dove essere ricchi diventa automaticamente una certificazione divina del fatto che stai facendo bene.
Non dico che tutti gli americani lo pensino, ma c’è questa sottile convinzione diffusa per cui se fai soldi non devi niente a nessuno e non devi vergognarti — anzi, devi andare avanti come un treno.
È proprio questo l’inganno della comunicazione di certe aziende: hanno passato anni a trovare modi creativi per non pagare tasse, che è forse la forma massima di anti-inclusione possibile, salvo però poi quando si preoccupano dell’assicurazione sanitaria o della cultura inclusiva, sì, ma solo dentro i loro uffici. La comunicazione, quindi, supera sempre la sostanza in termini di valore e rilevanza.
È tutto un gioco di compensazioni. Non è casuale, allora, che appena arriva un cattivo vero al comando, questi brand si mettano subito in fila.
Qualche giorno fa il capo dell’FBI ha deciso di eliminare una sezione dedicata ai diritti delle donne interne all’agenzia, definendola "uno spreco". Giusto per capire il clima.
E intanto, sul fronte normativo, le differenze tra Stati Uniti ed Europa cominciano a diventare enormi, specie ora che dall’altra parte dell’Atlantico c'è quest’aria da “liberi tutti”.
L'anno scorso hai pubblicato il tuo primo libro, L'invenzione del boomer, edito da UTET, in cui cerchi di costruire un dialogo tra generazioni apparentemente distanti, come i boomer e i millennial. Su cosa si basa questo tentativo di avvicinamento?
Ogni volta che qualcuno se ne esce con frasi tipo: “Ah, la musica di oggi, i film di oggi… ai miei tempi erano tutta un’altra cosa”, in realtà sta facendo una distorsione prospettica clamorosa.
Quei gusti che ti sembrano universali e oggettivi sono invece legati alla tua vita, ai tuoi ricordi, ai tuoi amori, alle tue esperienze. Quindi ogni volta che ti viene l’istinto di demolire i gusti dei giovani, ecco, quello è proprio il momento di stare zitto.
Non è la musica a peggiorare, sei semplicemente tu che stai invecchiando.
Scrivere che tra boomer e millennial esista una frattura insanabile mi sembrava una banalità pazzesca e poco interessante da raccontare in un libro. Ho preferito immaginare quel conflitto come uno spazio non solo di scontro, ma anche di scambio, di dialogo vero.
D’altronde, non è una novità che le generazioni si scannino fra loro accusandosi a vicenda di essere diventate molli. È sempre stato così: perfino nell’Iliade gli anziani guerrieri accusavano i giovani di non essere abbastanza tosti.
Poi certo, adesso c’è pure la questione del “ci avete rubato il futuro”.
Però, a ben vedere, questa contrapposizione tra millennial e boomer è almeno una scintilla interessante rispetto al pessimismo apocalittico generale del “Moriremo tutti”. Insomma, ci vedo anche qualcosa di positivo.
Informare seriamente non vuol dire annoiare mortalmente: 4 cose che ci portiamo a casa
Serietà e leggerezza possono (anzi devono) convivere
Un contenuto efficace non deve per forza essere noioso o impostato. Si può essere profondi anche con ironia e leggerezza, perché saper dosare informazione e intrattenimento è la vera chiave per mantenere vivo l’interesse delle persone, soprattutto oggi che l’attenzione è un bene prezioso.Andare sempre oltre il prevedibile
Le storie più affascinanti si nascondono negli angoli meno frequentati: dettagli apparentemente insignificanti, aneddoti marginali. Guardare dove gli altri non guardano porta alla scoperta di idee originali e sorprendenti. In un panorama saturo di informazioni superficiali, distinguersi significa saper trovare il valore nell'improbabile, nell’inatteso e nel curioso.Una community vale più di mille click
Creare appartenenza è molto più potente del semplice traffico o della viralità. Il vero successo editoriale o creativo si fonda su un pubblico che ti segue perché sente di condividere valori e passioni con te. Quando le persone sentono di essere parte di qualcosa, la fedeltà diventa spontanea e duratura.Basta nostalgia: dialogare è necessario (e anche divertente)
Criticare il presente perché diverso dal passato non porta da nessuna parte. Il dialogo fra generazioni, anche distanti, non è solo possibile ma è necessario e può essere sorprendentemente stimolante. Non è la musica o la cultura a peggiorare col tempo: la musica, semplicemente, cambia, e il confronto tra passato e presente è un’occasione per scoprire prospettive nuove, mettersi in discussione e trovare punti di incontro che arricchiscono tutti.